Una delle caratteristiche distintive del dialetto salentino è l’aferesi delle vocali, in particolar modo nei verbi con prefisso.
esempi:
alzare: źźare, incollare: ncuḍḍare, insultare: nzurtare, acconciare: ccunzare
Per effetto di tale fenomeno, come si può notare, si verifica una riduzione del numero delle sillabe che costituiscono la parola. Mentre per tutti gli altri verbi ciò non produce alcun effetto, nella flessione dei verbi bisillabi si ha un recupero della vocale elisa in tutte quelle voci che altrimenti sarebbero monosillabiche (prima, seconda, terza persona singolare dell’indicativo e del congiuntivo presenti, prima singolare dell’imperativo) (1). Il fenomeno ricorre anche nella terza persona plurale, in analogia con la flessione di tutti gli altri verbi, per i quali detta voce è sempre modellata sulla terza singolare (in italiano sulla prima).
(1)Nel dialetto salentino, a differenza che nell’italiano, di norma non si trovano voci verbali monosillabiche, anche al di fuori del caso sopra prospettato. Per evitarle, si ricorre all’epitesi o all’epentesi. Si vedano, per esempio, i verbi “stare” (“stau“, stave“, “stane“, “statte“), “fare” (“fane“), “dire” (“dine”).
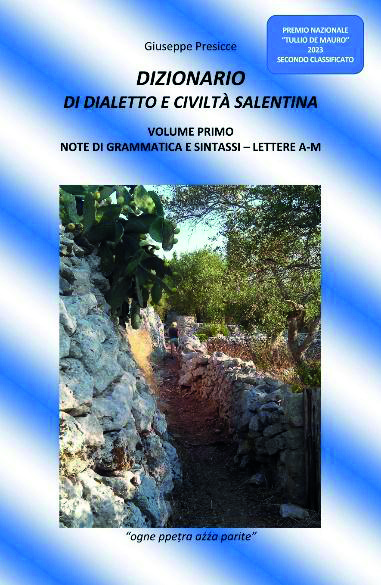
sig. it.: nausea. etim.: dal ver. latino “abhorrēre“: sentire avversione, ripugnanza. var.: burrenzia. sin. gen. an.: ggiramentu de stòmmicu, nausia. con. ant. inv.: ula, misìa, spilu, site, smania, siggenza, disideriu, fame, famòtica, ppetitu, spàzzula.
sig. it.: Agata. dim.: Catùccia.
sig. it.: ascesso. etim.: dal latino “abscessu(m)”, stesso significato. sin. gen. an.: frunchiu, parròzzulu, paḍḍòzzulu, fau.
sig. it.: (avv.) chissà, forse. note: propriamente il termine è la seconda persona dell’imper. del ver. “acchiare“. Esso, in unione con una congiunzione, può introdurre una proposizione subordinata, con i seguenti significati: dubbio: “àcchiacu”: chissà se, possibilità: “àcchia ca”: forse, ipotesi: “acchia ca”: se, qualora. es.: Acchia aḍḍu stave. Chissà dove sta. Acchia cu cchiove. Chissà se piove. Acchia ca vene, cce li dicimu? Se viene, che cosa gli diremo? Acchia ca vene. Forse viene. sin. gen. an.: semài, se, ci, facciamu, casu mai, ṭroa ca.
acchiare: vedi cchiare
sig. it.: tesoro riportato alla luce. etim.: da “acchiare“: trovare. var.: cchiatura. es.: Quiḍḍu s’à rricchiutu cu nn’acchiatura! Quello si è arricchito grazie a un ritrovamento! sin. gen. an.: tesoru.
cchiare
aceḍḍu
sig. it.: uccello. etim.: da un presumibile “avicellu(m)”, diminutivo del classico “avis“, stesso significato. m. d. d.: “càtene li ceḍḍi cretti“: fa un freddo cane. var.: ceḍḍu. es.: (detto) Lu cchiù fessa aceḍḍu se futte la meju fica. L’uccello più stupido si mangia il fico migliore. sin. gen. an.: pàssaru, cicì.
sig. it.: chicco, granello, minima quantità. etim.: dal latino “acĭnu(m)”: grano, acino. locuz.: “n’àcinu de sale”: un granello di sale (in senso sia reale che metaforico); “n’àcinu de pipe”: un granello di pepe. es.: Me dai ddo àcini de ua? Mi dai due chicchi di uva? Manca sulu nn’àcinu de sale. Manca soltanto un granello di sale. Tie nu tteni an capu mancunn’àcinu de sale. Tu non hai un grano di buon senno. sin. gen. an.: na punta, nu picchiceḍḍu.
sig. it.: (detto di cibi o bevande) acido, (detto di persone) astioso e malevolo. etim.: dal latino “acĭdu(m)”: aspro, acido. note: il termine è usato anche come sost. m. d. d.: “dare all’àcitu“: inacidire, (traslato) detto di persona che parla o si comporta in modo allusivamente lubrico, indecente, scon-veniente. es.: Stu latte è ddiventatu àcitu. Questo latte è inacidito. L’acqua osci sape de àcitu fènicu. L’acqua oggi sa di fenolo. Nunn’aggiu mai vista na cristiana àcita comu a ttie. Non ho mai visto una persona acida come te. sin. gen. an.: nnacarutu, rrancitutu, ràncitu.
acqua
sig. it.: acqua, pioggia. etim.: dal latino “aqua(m)”, stesso significato. es.: (detto) Lu sangu nu sse po’ ffare acqua. Il sangue non può diventare acqua. Sta rria l’acqua. Sta per arrivare la pioggia.
di Giuseppe Presicce, già dirigente scolastico, cultore di dialetti salentini



